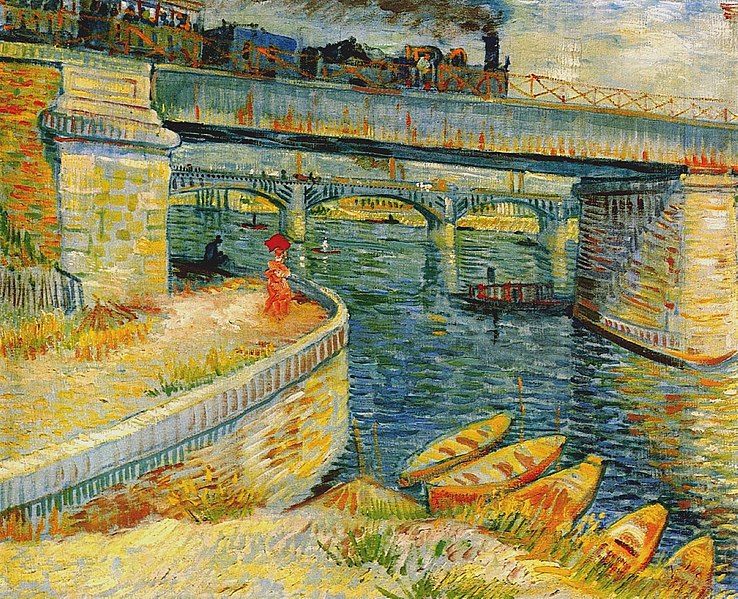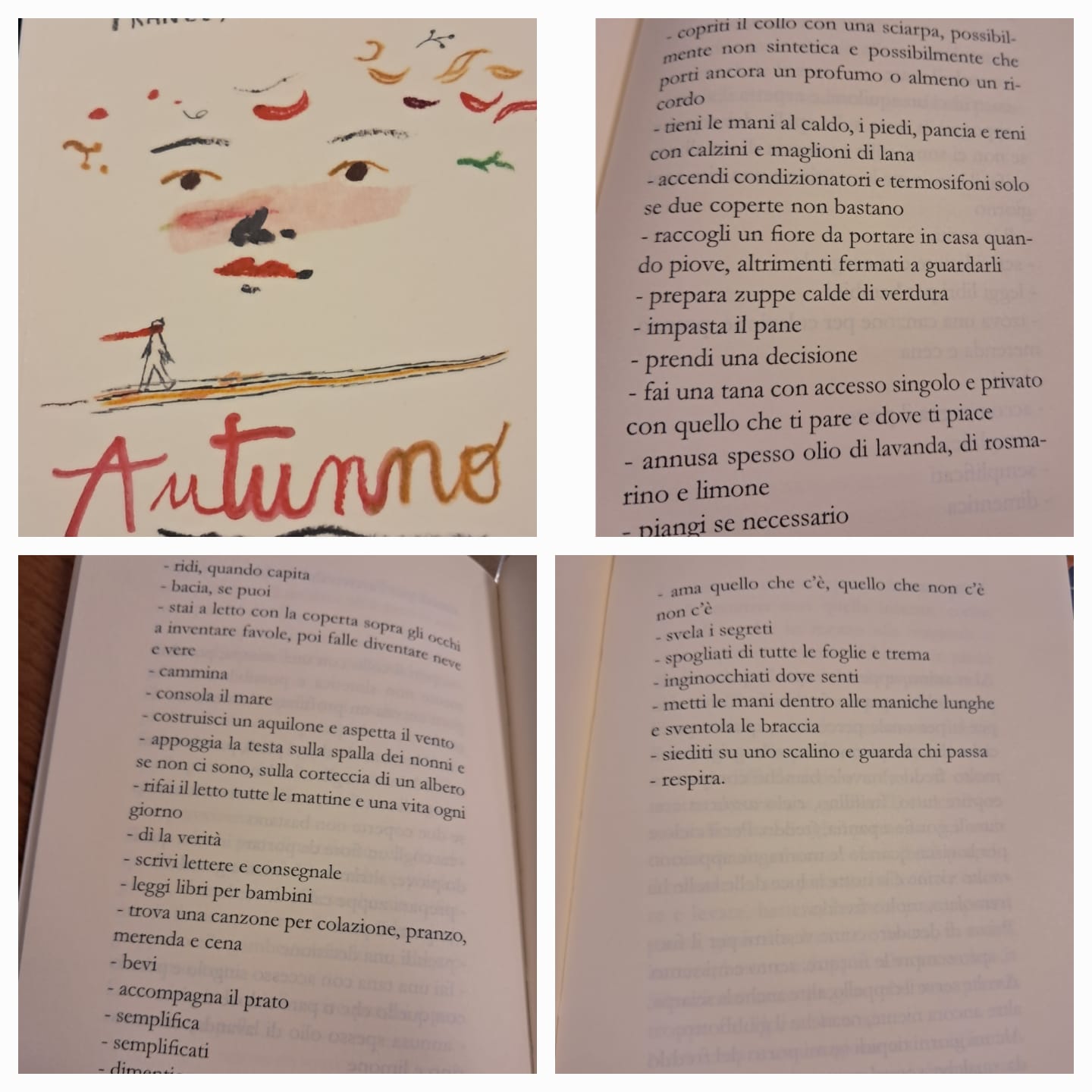Ritrovarsi – di Carmela De Pilla

Rivederla aveva rinnovato in me emozioni così forti che mi appoggiai al vecchio eucalipto ancora rigoglioso e rassicurante.
La grande casa mi aveva accolta bambina e nonostante il tempo avesse cancellato l’armonia che vi regnava apparve ai miei occhi pregna di sorrisi e allegria, non si sentivano più le risate dei bambini che rincorrevano le galline o i canti notturni, ora se ne stava solitaria e abbandonata a se stessa ricordando con un po’ di nostalgia un tempo troppo lontano.
In quella pianura avvolta dall’aria salmastra del mare poco distante erano state costruite molte case con la riforma fondiaria che assegnava ai contadini più bisognosi qualche ettaro di terra e l’abitazione, erano tutte uguali queste case con grandi spazi atti ad accogliere famiglie numerose.
Tutto sembrava come allora, il pozzo era sempre lì e rivederlo così piccolo e spaventato mi fece sorridere perchè da bambina mi sembrava gigantesco e quando mi chiedevano di tirare l’acqua col secchio avevo una gran paura di caderci dentro! Solo l’intonaco scortecciato, le finestre sbarrate e il grande silenzio che la circondava mi fecero capire che fosse abbandonata da molto tempo, rividi i miei zii indaffarati a tramestare nell’aia e i miei cugini più grandi di me che ci tenevano impegnati facendoci giocare con legnetti, pietre, sassolini e una vecchia palla e per un attimo ritornò a vivere.
Il grande arco che portava a una veranda chiusa era ancora intatto, mi avvicinai, gli antichi ricordi riaffiorarono con prepotenza: nel mezzo il grande tavolo, una panca e qualche sedia, un mettitutto avorio profilato di azzurro appoggiato alla parete e accanto una stufa a legna dove la zia con poco faceva mangiare tutti.
Ci andavamo d’estate quando la scuola chiudeva e l’attesa dell’arrivo dei miei genitori diventava insopportabile, ci riparava dalla tristezza, lì potevo assaggiare l’amore di cui ero privata.
Tante case sparse in qua e in là e tante vite abbandonate a se stesse, in balìa di un destino che se ne fotteva dei loro dolori nascosti con pudore e dignità, ma loro non si abbattevano, sapevano che le battaglie vanno combattute con coraggio, senza troppi lamenti e ogni giorno sfidavano quel destino cieco e sordo e inventavano momenti di allegria per dare un po’ di tregua ai loro poveri cuori.
Nelle sere d’estate quando la frescura rasserenava gli animi uomini, donne e bambini si trascinavano lungo l’unica strada bianca che collegava le case e spesso si fermavano nell’aia della zia che accoglieva tutti sotto il grande eucalipto offrendo loro la sedia e lo zio pronto a raccontare aneddoti divertenti e a intonare canzoni popolari portava allegria e spensieratezza mentre i più piccoli andavano a giocare sotto il grande fico dove un’altalena li aspettava con le loro grida di gioia.
Le porte erano chiuse e attraversai la stalla confinante con la veranda, per un attimo sentii l’odore della paglia mista al letame e lo scalpitio di Stellina, la giovane cavalla tanto temuta e allo stesso tempo amata, forzai la vecchia porta sgangherata e mi trovai sul retro della casa, il forno trasformato dallo zio in una conogliera era sempre lì e c’era pure la recinzione del pollaio dove io e mio fratello andavamo a prendere le uova.
I ricordi si accavallavano e mi rividi con mio fratello mentre portavamo a pascolare i tacchini di cui io avevo grande paura e quando aprivano la coda a raggiera e sentivo quel verso buffo e assordante “gluh gluh gluh” mi stringevo a lui che come un bravo pastore mi proteggeva.
-Se volete mangiare dovete faticare!- Diceva scherzosamente lo zio, ma noi lo prendevamo sul serio e senza fiatare andavamo soli soletti in quei grandi campi abbandonati. E poi arrivava il tempo della vendemmia che avveniva prima del nuovo anno scolastico e la pigiatura dell’uva, un rito che si ripeteva ogni anno si trasformava in un vero e proprio momento di gioia, entravano nel grande tino prima le mie cugine e quando l’uva era già schiacciata facevano salire anche noi che cantando le canzoncine imparate a scuola ci divertivamo a saltare e ballare senza preoccuparci troppo di sporcarci assaggiando quel dolce succo d’uva che ci imbrattava il viso trasformandolo in una maschera, si comprava così una giornata di divertimento senza spendere nulla.
Osservavo con meticolosità come se fossi andata lì per vedre se tutto era a posto poi ritornai sotto l’eucalipto e mi sedetti per terra e nel toccare la terra dura e ormai arida mi venne in mente il grande falò di quella sera…eravamo tanti, gli adulti seduti sulle sedie e i più piccoli per terra, dopo la calura del giorno i vicini si erano ritrovati come spesso accadeva dai miei zii e seduti a formare un grande cerchio raccontavano gli ultimi fatti, gli uomini si accanivano contro la siccità o il governo che pagava poco i prodotti, le donne parlavano sottovoce degli affanni quotidiani e i bambini giocavano ai “ cinque sassolini “, io ero diventata esperta e nelle gare vincevo quasi sempre, era questione di abilità e di allenamento e quando nell’ultimo passaggio buttavo in aria i cinque sassi riprendendoli con una mano sola ero la bambina più felice del mondo.
Era buio da qualche ora e s’incominciava a sentire il freddo della notte così gli uomini fecero un grande falò nel mezzo del cerchio e all’inizio qualcuno intonò timidamente una canzone poi se ne unirono altri e altri ancora e nell’aria oltre alle scintille e alle fiamme che si rincorrevano si spandeva un’unica voce che saliva con slancio, quasi con violenza fino all’alto dei cieli come a voler dire ”Ascoltate, ci siamo anche noi.”