Colibrì 2 e Colibrì 1 – di Gabriella Crisafulli
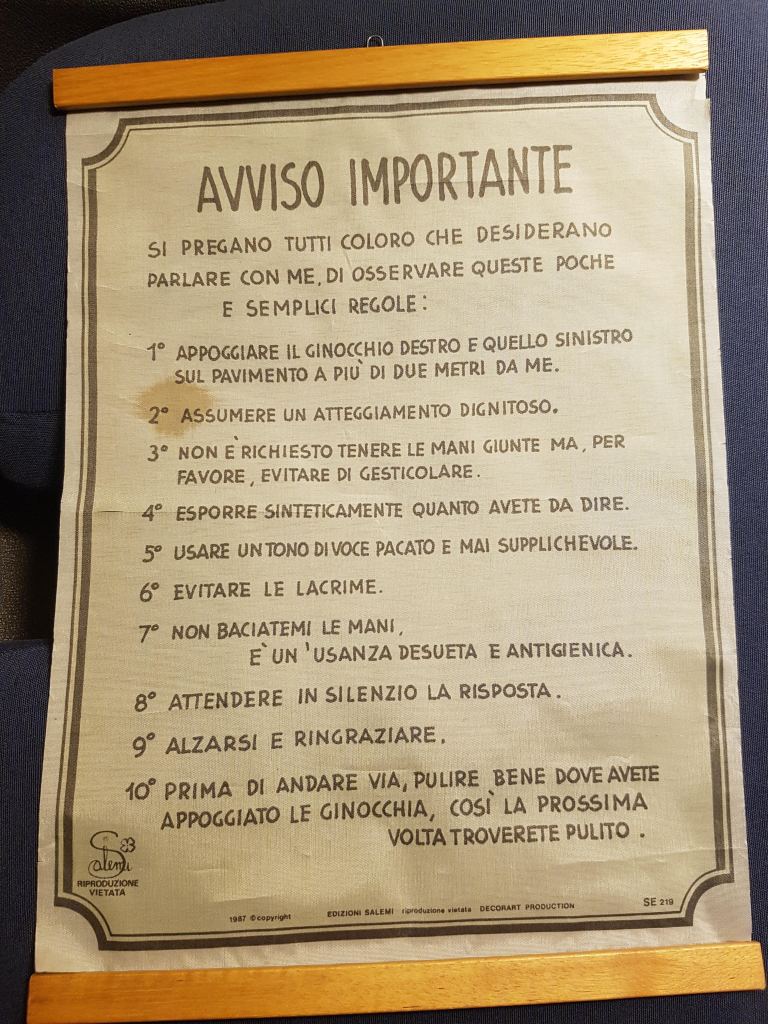
Era fortunata, era molto fortunata.
Doveva assolutamente riconoscerlo.
Stava male ma se lo poteva concedere.
Era libera di vivere le sue paturnie senza doverne rendere conto ad alcuno.
Aveva quel grande spazio a sua disposizione che era la rappresentazione plastica di ciò che aveva passato e che stava attraversando.
Era capace pure di mascherare all’esterno quel che provava con impeccabili recite che attingevano alle sue interpretazioni passate.
Cosa poteva desiderare di più?
È vero, aveva un problema: c’era quell’animalino che le dava fastidio perché le ricordava che non era ancora finita. Dopo tanti anni che si era data da fare per essere splendida splendente, tenace resistente, non era ancora finita e cominciava a domandarsi se sarebbe mai servito a qualcosa il lavoro di scavo che la impegnava giorno dopo giorno.
Tutti le ripetevano di buttare via tutto il ciarpame che la circondava ma fortunatamente non l’aveva fatto e dalla montagna di roba vecchia era venuto fuori quel reperto significativo: la inchiodava ad una storia che ciclicamente si ripresentava e lei poteva solo prenderne atto. Tutte le energie profuse per anni nel tentativo di una trasformazione, di un cambiamento non erano bastate: lei si trovava punto e a capo davanti ad uno specchio che le rimandava l’immagine di un mostro con cui doveva convivere.
Il colibrì le ricordava con fastidio che fin da un mese dopo la nascita aveva dovuto considerarsi come un adulto. Si era adattata e aveva imparato a battere le ali sessanta volte al minuto per rimanere assolutamente ferma, per non incorrere nelle ire di chi la circondava. Dopo settanta e più anni era ancora lì, immobile in “sur place”.
Le sue amiche le chiedevano come mai era sempre stanca: forse le era toccato in dote dalla vita un continuo consumo di energie, sempre avanti e indietro fra un compromesso e un altro con il risultato di risultare ambigua e deludente. Si era sempre barcamenata ma adesso la scialuppa era malconcia e non sapeva quale direzione prendere.
L’aveva fregata l’imprinting: le rammentava che non era Konrad Lorenz.
Per evadere a tutto ciò aveva incominciato a scrivere una storia sul dio Serpente che distruggeva mondo terreno e mondo divino per la rabbia di non essere stato preso in considerazione dagli uomini e dagli dei.
Aveva cercato di convogliare su qualcosa di diverso dalla sofferenza tutto il dolore che provava e la invadeva come melma.
Non sapeva ancora se sarebbe riuscita.
Sapeva solo che era fortunata, era molto fortunata.
Il suo mondo era popolato da altro, oltre ai rifiuti.
C’era chi le offriva un viaggio negli Stati Uniti e chi gliene proponeva uno ad Instanbul.
C’era chi ascoltava le sue geremiadi e chi rifiutava un caffè salvo poi pregarla di assaggiare i suoi dolcini.
C’era chi le suggeriva di indossare il rosso e chi le offriva un posto sul suo banco al mercato.
C’era chi le inviava almeno una canzone al giorno e chi le stava vicina nella sua fatica.
C’era il nipote che dall’Australia si rivolgeva a lei per ricostruire l’albero genealogico della famiglia.
D’altro canto Elena di Vacchereccia glielo aveva detto: “I parenti sono come le scarpe: più stretti sono, più male fanno.”
Colibrì 1
Nel fitto della foresta, al riparo dagli sguardi umani, molti e molti anni fa viveva il dio Huitzilopochtli con la consorte Kwakwaka’wakw. Aveva scelto quel posto perché era il luogo della felicità assoluta. Il cielo, la terra, le acque, gli animali, le piante, i colori, tutto era lussureggiante. Per rendere quel territorio ancora più ricco di vera gioia perenne il dio aveva creato i colibrì che dipingevano i giorni e illuminavano le notti con la loro danza perpetua.
Gli uccelli avevano la possibilità solo di sostare brevemente di tanto in tanto fra i capelli di Kwakwaka’wakw. Nella sua grande chioma proliferavano fiori di ayahuasca: generavano un nettare carico dell’acido lisergico che dava loro la vitalità per non stare mai fermi.
Nella capigliatura della dea i colibrì costruivano i nidi dove depositavano le uova che Kwakwaka’wakw covava con amore. Chiedeva ai colibrì, in cambio dell’ospitalità, le piume del manto fatte da un misto di turchese, lapislazzuli e ametista, per adornare le vesti e la chioma.
Erano gli uccelli più piccoli del creato, i più belli, i più leggiadri ma anche i più guerrieri che il loro becco a forma di spada combattevano per proteggere dai nemici. Il loro movimento continuo sosteneva ideali di forza, resistenza, perseveranza e dominanza sui nemici. Per questo motivo Huitzilopochtli li aveva mandati anche in mezzo agli uomini a cui donavano pure fertilità e abbondanza, allegria e resistenza, cura e aiuto, acqua e fuoco.
Il re Tizoc era grato agli dei di quel dono e venerava il colibrì a tal punto da immortalarlo nella Pampa di Ingenio con un enorme disegno visibile solo dall’alto.
In onore di dei così generosi, il sovrano sacrificava i giovani della propria stirpe e uomini e donne delle città vicine, bottino di conquista, immolandoli vivi sull’ara votiva.
Folle straboccanti si riunivano per vedere come le vittime venivano trucidate.
Durante il rito alcuni sacerdoti suonavano i sacri tamburi generando vibrazioni profonde che procuravano esaltazione mentre altri soffiavano nelle conchiglie scandendo un ritmo incalzante. Tutto intorno venivano alimentati incensari sulle cui braci sacre bruciavano le foglie di ayahuasca producendo il fumo che diffondeva esalazioni allucinogene.
La moltitudine si lasciava andare alle danze mentre il sangue colava dall’ara votiva giù giù lungo il piano inclinato della piramide fino alla gente che se ne bagnava i piedi ballando nella polvere.
La danza cerimoniale, all’inizio, si sviluppava in cerchi concentrici generando un movimento cosmico e poi si estendeva in una catena umana, in un serpente infinito.
Una volta però, all’inizio della fine di quei giorni, il ballo ossessivo generò nel suo snodarsi un vero serpente, un rettile gigantesco e mostruoso che divorò la gente e nel contorcersi si fece prima arco e poi freccia lanciandosi nel territorio degli dei.
Era Quetzacoalt, il dio serpente, che era stato mandato nel mondo sotterraneo perché la sua orrida figura spaventava Kwakwaka’wakw di cui era innamorato.
Quella volta, i balli ossessivi nel corso dei quali si inneggiava al re Tizoc, avevano creato una fenditura nel terreno e Quetzacoalt ne aveva approfittato per venire fuori dal sottosuolo: voleva dare sfogo alla sua rabbia, alla sua gelosia, alla sua violenza.
Era l’ora della resa dei conti e non se la fece scappare. Voleva punire il sovrano perché non gli aveva dedicato sacrifici umani, voleva dominare il mondo dell’abbondanza e voleva che Kwakwaka’wakw fosse sua.
Ma il dio serpente, però, non sapeva che rabbia, gelosia e violenza, nel momento stesso in cui mettevano piede nel luogo della felicità assoluta, ne cancellavano l’esistenza insieme a lui ed a tutti gli uomini che veneravano Huitzilopochtli e Kwakwaka’wakw.
Di tutta quella magnificenza dopo tanti secoli rimane una radura nella foresta che, vista dall’alto, disegna un colibrì e migliaia migliaia di microscopici uccelli colorati diffusi in tutta la foresta.
Con il movimento delle ali simboleggiano l’infinito, l’eternità e invitano gli uomini a lasciar andare il passato per fare spazio ad un nuovo ciclo di vita.
